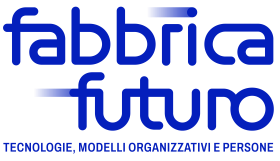Produttività, solo la cultura industriale ci salverà

Una delle maggiori cause del degrado della competitività del sistema Italia rispetto alle economie concorrenti è stata la continua mancanza di una strategia industriale di Paese. Tale mancanza è figlia di vari fattori concomitanti. Per esempio l’incompetenza e la non coincidenza tra le necessità italiane e gli obiettivi della classe politica.
Ma anche i sindacati non hanno voluto capire il forte cambiamento determinato dalla competizione globale e dalle nuove tecnologie mantenendo un orientamento ossessivo al mantenimento dei posti di lavoro anche in business non sostenibili (vincolando il trasferimento di investimenti e lo sviluppo di competenze per lo sviluppo di quelli nuovi). Non ultimo il ruolo frenante delle associazioni di categoria con i loro interessi puramente protettivi e corporativi.
C’è però un substrato che ha concorso a tutto ciò e che ha condizionato lo sviluppo delle singole aziende. Si tratta della cultura delle persone che ha determinato tali atteggiamenti e comportamenti attraverso il loro ruolo. Esiste quindi un problema culturale di fondo, presente in Italia più che altrove, che accomuna tutti (imprenditori, manager, funzionari, politici, sindacalisti, consulenti, scuole di formazione, professori, ecc.). Molti non hanno ancora completamente assimilato i nuovi paradigmi di business della competitività globale in ambiente digitalizzato. Tale gap culturale costituisce il principale freno per i necessari cambiamenti. Non si è capito – e si continua ancora a non capire bene – come debbano essere modificati i modelli di business per competere nei nuovi scenari competitivi. Non è stata dunque ben recepita la necessità di cambiare le strategie di business.

Il basso analfabetismo funzionale di business
L’Italia si presenta molto arretrata (al 178esimo posto su 180) nell’alfabetismo funzionale generale (quello di livello tre previsto dal modello Ocse che individua la capacità di interpretazione logica delle situazioni): siamo analogamente arretrati in quello che si può chiamare ‘alfabetismo funzionale di business’, cioè la capacità di capire il nesso tra i cambiamenti del mercato e dei modelli di business e le priorità strategiche e operative per adattarsi a essi. O, meglio, capire come approfittare del cambiamento per riposizionarsi in modo più competitivo nel nuovo scenario. Per intendersi si può riproporre la vecchia massima: “Perdente è l’imprenditore che vede i cambiamenti come un problema; vincente è colui che vede nei cambiamenti nuove opportunità”. Le eccezioni a riguardo, cioè quei casi che i mainstream ci presentano come esempi della grande capacità innovativa delle imprese italiane, costituiscono proprio la prova di ciò. Se siamo così innovativi, come mai perdiamo posizioni rispetto agli altri Paesi? Come mai tali prodotti-servizi innovativi (in teoria quindi a maggior valore unitario) non fanno crescere il Prodotto interno lordo pro-capite, come avviene invece nei Paesi concorrenti? La risposta è, ovviamente, facile: la percentuale di tali innovazioni è troppo bassa ed è in genere fatta da Piccole e medie imprese (PMI) che riescono a sviluppare il relativo business in quantità molto limitata. Servirebbero innovazioni da parte di grandi aziende con ingenti fatturati e volumi, ma purtroppo non ne abbiamo più a sufficienza: sono praticamente sparite imprese con base italiana in grado di competere a livello globale con prodotti innovativi.Ci servono prodotti e servizi più innovativi
Venendo al punto della cultura di business, il focus è su quella di base, cioè quella che ci portiamo dietro dai tempi del boom economico dell’Italia. Si tratta delle convinzioni di strategia industriale, che di fatto non sono cambiate molto dagli Anni 70 e che, in buona parte, appartengono ai nostri imprenditori e manager. Sono convinzioni completamente inadeguate alla realtà del business internazionale odierno (ma anche degli ultimi 30 anni). Le più pericolose culturalmente per il nostro sviluppo economico sono: la produttività si aumenta attraverso l’aumento dell’efficienza; piccolo è bello; il fatturato si aumenta con l’aumento dei volumi produttivi. Cominciamo con il tema della produttività. Il livello di produttività di una azienda (ma anche di un Paese) è dato dal rapporto valore prodotto-costo per produrlo. Si può dunque aumentare la produttività aumentando il numeratore o riducendo il denominatore. La cultura che ci portiamo dietro (quella del periodo del boom economico) riteneva che per aumentare i fatturati delle aziende fosse sufficiente aumentare i volumi di ciò che si produce. Allora, giustamente, si dava per scontata la possibilità di vendere i prodotti fabbricati in più, in quanto i mercati erano insaturi, e quindi pronti ad assorbire gli aumenti di volume di prodotti-servizi. In tal caso l’efficienza delle risorse di produzione era la leva prioritaria per aumentare i fatturati: era sufficiente efficientare la produzione (era l’era dei Tempi e Metodi tayloristici), automatizzarla e robotizzarla e contemporaneamente ridurre i costi di produzione e aumentare la competitività sui prezzi. Per aumentare i margini, e/o ridurre i prezzi, era anche fondamentale il costo del lavoro. Nell’attuale realtà di mercati saturi (dagli Anni 90 in poi), l’aumento dei volumi produttivi non è affatto garanzia di maggior fatturato. Anzi, il risultato potrebbe essere facilmente l’aumento dell’invenduto. Se poi si persegue l’obiettivo di aumentare l’efficienza per ridurre i costi dei prodotti esistenti per essere più competitivi, occorre prendere atto che si rischia di confrontarsi con Paesi che hanno costi del lavoro strutturalmente inferiori ai nostri e che, magari, sono dotati di programmi di digitalizzazione (4.0) più importanti dei nostri. Nei mercati saturi si può aumentare i fatturati, e quindi il Pil nazionale e quello pro-capite, solo aumentando il numeratore attraverso un aumento del valore di ciò che si produce. Si tratta di saper concepire e produrre prodotti più innovativi, a maggior valore percepito e riconosciuto dal mercato (strategie di servitizzazione e i segmenti luxury, possono aiutare molto a riguardo). A tal proposito, è utile dare priorità alla strategia che consenta alle aziende di ‘smarcarsi’ dall’assoggettamento totale ai grandi player dell’ecommerce. Tale canale, a fronte di chiari vantaggi per i consumatori, ha avuto, e sta avendo, un importante impatto negativo sul Pil nazionale e sulla stessa esistenza e possibilità di sviluppo delle nostre imprese.L’articolo integrale è pubblicato sul numero di Marzo 2023 di Sistemi&Impresa.
Per informazioni sull’acquisto di copie e abbonamenti scrivi a daniela.bobbiese@este.it (tel. 02.91434400)
Giorgio Merli è Consulente di multinazionali e governi, Docente in università in Italia e all’estero, già Country Leader di IBM Business Consulting Services, CEO di PWCC, Senior VP di Efeso Consulting.
competitività, produttività, strategia industriale