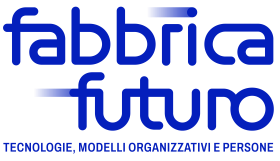Il grande freddo della deflazione. Per crescere servono le riforme

Consumi al palo. Stipendi bloccati. E investimenti delle aziende congelati.
L’indice dei prezzi al consumo continua a scendere (di poco) su base annua.
Un problema da non sottovalutare se l’obiettivo è tornare a crescere
di Carolina Parma
In base ai dati Istat ad aprile l’indice dei prezzi al consumo ha registrato una flessione dello 0,4% su base annua. Tecnicamente, anche se si tratta di una diminuzione minima, secondo i manuali di economia, l’Italia è in deflazione. Ma, “guardando l’indice generale dei prezzi”, osserva Francesco Daveri, docente di Politica Economica all’Università Cattolica di Piacenza, “si può notare che i prodotti con prezzi che viaggiano a testa in giù sono poco più del 50%; gli altri reggono e ci sono anche quelli che hanno registrato incrementi, come i beni durevoli, dalle auto ai cellulari, che mediamente sono aumenti più dell’1% rispetto a 2015; anche il prezzo dei servizi è salito dello 0,5% sull’anno scorso”. In generale si difendono bene i settori e le aziende con un alto know how e valore aggiunto, molto customizzate e per i quali “il fattore prezzo è una variabile meno influente”, spiega Andrea Pignagnoli, analista economico Euler Hermes Italia. “Tra queste ci sono per esempio le imprese che costruiscono macchinari specialistici o che operano nel settore biomedicale, oreficeria, lavorazione del marmo.
“Per loro, spesso una dinamica dei prezzi discendente rappresenta un’ulteriore spinta. Il problema, semmai, si pone per i margini, ossia se i costi di approvvigionamento dei fattori produttivi utilizzati nella lavorazione hanno una dinamica superiore ai prezzi di vendita”, continua Pignagnoli. Un quadro variegato, insomma, che include anche comparti in deflazione da prima dell’inizio della crisi economica a dimostrazione del fatto che non sempre il calo dei prezzi è legato alla discesa dei consumi. “Il segmento del largo consumo, per esempio, è uno di questi: qui, infatti le cause del calo dei prezzi sono legate alle dinamiche della grande distribuzione organizzata da una parte e alla forte concorrenza cinesedall’altra”, avverte Daveri. “Da quando nel 2001 il Dragone è entrato nel Wto si è innescata, infatti, una pressione al ribasso dei prezzi di beni che maggiormente soffrono la concorrenza di prodotti provenienti da quel mercato, come i capi di abbigliamento o gli accessori moda”. Stessa cosa vale per le aziende che operano nel settore del largo consumo che da anni subiscono il potere della grande distribuzione. “La Gdo e i discount seguono politiche commerciali che portano a un abbassamento costante dei prezzi e a subire il colpo sono le aziende di marca, che devono negoziare la loro presenza sugli scaffali. Per i consumatori è un vantaggio, ma le imprese vedono i loro margini abbassarsi sempre più”.
Casi particolari a parte, resta il fatto che l’andamento dei prezzi al consumo da inizio 2016 subisce saliscendi minimi, che impattano ben poco sull’andamento reale della nostra economia, da tempo ingessata. I consumi non ripartono, le aziende non investono, i posti di lavoro non aumentano in modo deciso, gli stipendi sono bloccati. Un mercato impantanato, che annaspa, perde forza e non riesce a trovare vie di uscita.


Urgono riforme
Il vero problema, infatti, è la crescita economica modesta, non la deflazione di pochi decimali. Per ridare la fiducia a imprese e consumatori, la Banca centrale europea (Bce) nei mesi scorsi ha abbassato i tassi di interesse portandoli a livelli bassissimi o sottozero. “Ma inondare di liquidità il sistema non basta se, come dicono gli economisti, il cavallo non vuole bere”, prosegue Pignagnoli. “Il problema ha due facce: una domanda europea modesta e una dinamica dei prezzi all’import (soprattutto delle materie prime), in flessione. Per rilanciare la domanda ci vorrebbe un piano di investimenti di grandi dimensioni, sovvenzionato con obbligazioni garantite dalla Bce, in modo da spingere anche l’occupazione e la domanda interna. Per la dinamica dei prezzi all’import bisogna invece attendere l’esaurimento del ciclo ribassista, molto legato agli acquisti della Cina”, afferma convinto l’analista economico di Euler HermesItalia. E il governo italiano non deve stare a guardare. Per ridare fiato all’economia interna è vitale portare avanti le riforme il più velocemente possibile, lavorando su più fronti. “A partire dalla riforma della Pubblica amministrazione, fondamentale per abbassare i costi dello Stato”, prosegue Daveri, operazione che avrebbe ricadute positive anche sulla pressione fiscale, ancora troppo alta in Italia, sia per le imprese sia per le persone fisiche. Anche la riforma del sistema bancario dovrebbe accelerare perché in assenza di credito le persone e le aziende non si indebitano e il sistema si paralizza”. Senza dimenticare la riforma fiscale. È vero, nel 2016 sono state azzerate Imu e Tasi sulla prima casa con il tentativo di rilanciare il mercato immobiliare da tanti anni in sofferenza. L’anno prossimo dovrebbero scendere le tasse sui profitti delle società e il 2018 dovrebbe essere l’anno della riduzione dell’Irpef. Ma fino a ora l’alleggerimento fiscale è stato piuttosto limitato. Discorso diverso va fatto per la riforma del lavoro, l’unica che è stata portata avanti dal Governo, “peccato che i risultati non siano stati tanto positivi come si sperava”, commenta Daveri. “Per il momento la ripresa del mercato si calcola in circa 200mila posti in più, ma va detto che crearli è stato molto costoso perché si è fatto ricorso alla decontribuzione, il che significa che si sono fatti pagare allo Stato i contributi che avrebbero dovuto versare aziende e lavoratori”. Dunque con una riduzione di oneri contributivi solo temporanea. “I posti di lavoro si creano se i fatturati delle aziende salgono e se ci sono riduzioni di imposta permanenti per le imprese. Ma i fatturati crescono poco e le agevolazioni fiscali per chi assume sono in diminuzione. Morale: l’occupazione non è ancora una molla su cui fare leva per ripartire”, è la tesi del docente di Politica Economica all’Università Cattolica di Piacenza.Banche, più advisor meno contabili
La molla per ripartire non è nemmeno il nostro sistema bancario. Almeno non loè stato finora anche per l’incapacità di comprendere a fondo le necessità delle imprese nazionali alle prese con mercati sempre più complessi. “Nel loro rapporto con le aziende dovrebbero adottare un approccio di settore industriale”, interviene Gennaro Casale partner di Boston Consulting Group e responsabile Financial Institution per Italia, Grecia e Turchia. “Un modello che le banche Usa seguono già da un decennio e che negli ultimi anni ha preso piede anche in alcuni istituti europei, ma che in Italia fa ancora fatica a svilupparsi perché richiede un cambiamento culturale profondo”. Il rapporto delle nostre banche con le imprese è, infatti, ancora centrato prevalentemente sulle linee di credito e sul loro prezzo. Invece per le banche l’opportunità è diventare partner a tutto tondo degli imprenditori, attraverso la comprensione delle dinamiche del settore industriale dove questi operano. “Oggi le aziende richiedono un advisor che le possa accompagnare nel capire il contesto competitivo del settore industriale dove operano, le dinamiche dei clienti e dei competitor, il quadro internazionale” spiega Casale. “Hanno bisogno di consigli su dove vale la pena investire. Gli economics dell’agroalimentare sono diversi rispetto a quelli della meccanica o dell’abbigliamento”. Non a caso negli istituti di credito esteri stanno sviluppando competenze specifiche in determinati settori industriali, il che vuol dire che stanno lavorando per avere al loro interno manager che provengono da settori industriali in grado di diventare validi advisor per le aziende “e di dare suggerimenti per la creazione di prodotti finanziari specifici per un determinato settore industriale”, prosegue Casale. Questo significa avere un approccio alla valutazione di merito creditizio differenziato da settore a settore e per poterlo fare è necessario avere all’interno della banca analisti del credito specializzati in diversi segmenti produttivi. “L’evoluzione del rapporto banca-impresa su queste basi può dare buoni ritorni”, suggerisce Casale e non solo per le imprese, ma anche per gli istituti di credito che potrebbero spingere servizi paralleli come la copertura del rischio impresa, servizi transnazionali di cash management e tutti quelli legati al trade finance. Tutti business attrattivi per le banche perché hanno minore assorbimento dicapitale rispetto al credito tradizionale e sono di natura commissionale”. Una trasformazione che richiede tempo, anche perché prima di concentrarsi sulle imprese le nostre banche devono mettere ordine nei loro bilanci. Il Fondo Atlante e la riforma bancaria possono aiutare, ma i risultati si vedranno nel tempo. Intanto la maggior parte delle nostre aziende resta nel limbo.