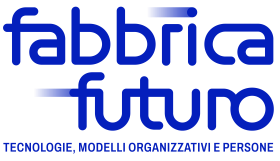Gli esseri umani nella fabbrica italiana del futuro

Il doppio ruolo delle gigafactory
All’inizio di luglio 2021 ogni organo di informazione italiano ha registrato, con note di giubilo, le parole di Carlos Tavares. L’Amministratore Delegato di Stellantis, l’azienda automobilistica nata dalla fusione dei gruppi Psa e Fiat Chrysler Automobiles, annunciava l’apertura in Italia della propria terza gigafactory europea. La dichiarazione è stata accolta con unanime soddisfazione dalla politica e dal sindacato. Dovremmo gioire perché ci saranno nuovi posti di lavoro, quando questi sono una miseria rispetto a quelli persi dall’industria automobilistica italiana. I posti di lavoro persi non tornano: in quegli stessi giorni, crescono i livelli di produzione in uno stabilimento italiano del settore automotive: la Sevel della Val di Sangro. Ma non cresce corrispettivamente il numero degli occupati, bensì solo quello dei somministrati. Dovremmo anche gioire perché siamo terzi. Dopo Germania e Francia. Paesi dove l’occupazione nell’Automotive non è crollata come da noi. In Germania, si sa, ci sono tre grandi gruppi automobilistici, solidamente in mani tedesche. In Francia ce ne sono due. In Italia ne avevamo uno ed è ora evidente che non l’abbiamo più. La strategia di Stellantis, infatti, è a trazione francese. Tavares era Amministratore Delegato di Peugeot e ora lo è della nuova società. La famiglia di imprenditori che aveva fondato e guidato per un secolo la Fiat si è ridotta a una malinconica accolita di rentier. E, in ogni caso, il management di Stellantis, non è interessato a una politica industriale. È impegnato a garantire il valore di Borsa del titolo e i livelli di profitto agli shareholder. Deve far riflettere l’espressione “gigafactory”, che trasuda retorica dell’iper, dell’hype. L’abbondanza promessa dal digitale – per come la storia viene raccontata ai cittadini ignari – sembra non aver limite. Esistono numerose descrizioni giornalistiche, tecniche, scientifiche e accademiche. In ogni caso il senso della gigafactory si riassume in due aspetti chiave. Si tratta di fabbriche adeguate a volumi di produzione variabili e tendenzialmente crescenti. E allo stesso tempo si tratta di fabbriche il cui governo è garantito da una precisa gestione remota dei processi. Un sistema di produzione dove il luogo è irrilevante e dove le modalità di produzione sono riconfigurate in tempo reale, attimo dopo attimo, tramite una gestione a distanza dei costi, dei processi e dei ritmi. Il governo si esprime tramite algoritmi, il cui contenuto strategico è ignoto e invisibile agli occhi sia del management di fabbrica sia delle organizzazioni dei lavoratori. Un’enorme struttura, gigantesca fabbrica autosufficiente, autonoma rispetto al territorio stesso in cui è inserita. Dunque, di fatto, disinteresse per clienti, lavoratori e comunità sociali e invece subordinazione a obiettivi finanziari. La gigafactory prevede, temporaneamente, la presenza di lavoro umano, ma è progettata in modo da essere potenzialmente una light-out factory: una fabbrica con un numero variabile, ma volendo tendente a zero, di lavoratori (Sjödin et al., 2019; Sharma et al., 2019; Cooke, 2021).Il lavoro umano e la manifattura delle PMI italiane
La situazione della politica italiana è sotto i nostri occhi. Grandi stabilimenti dismessi. Capitale di comando in mani straniere, affidato ai voltabili movimenti del mercato finanziario. Ministero dello Sviluppo Economico intento ad aprire nuovi tavoli per difendere l’occupazione in stabilimenti comunque destinati alla chiusura. Manodopera in Cassa integrazione. Una gigafactory temporaneamente allocata nel nostro Paese non può bastare a invertire la tendenza. Dovremmo accontentarci di una fabbrica-scatola chiusa, progettata per essere gestita al di fuori di qualsiasi possibile osservazione da parte della politica italiana e dei sindacati dei lavoratori italiani? Non è così che si costruisce un futuro. Il domani della nostra Manifattura conviene cercarlo altrove. Nel mentre rincorriamo l’insediamento di qualche gigafactory: cavillose questioni politiche, burocratiche, finanziarie e fiscali frenano la media impresa italiana, invidiato e incompreso modello manifatturiero sul quale si regge l’economia del nostro Paese. Quando si guarda alle PMI, purtroppo, tendiamo a farlo con la pretesa di correggere e modificare, diventando così inconsapevoli esecutori di una strategia che vuole ricondurre a standard globale questa vincente eccezione italiana. Gli imprenditori delle PMI, pur intimiditi di fronte all’ostentata autorevolezza di tanti accademici e consulenti e tecnici formati nelle discipline Stem, restano per fortuna, salvo eccezioni, legati a un’intima convinzione, al territorio e alla propria storia (Polanyi, 1985). Si fondano sulla competenza in un mestiere, in uno specifico know how. Dalla sicurezza di detenere un mestiere discende lo spirito imprenditoriale che il mondo ci invidia (Varanini et al., 2001). Il cuore sta nel saper fare ‘pratico’, manifatturiero. Le radici stanno nel lavoro svolto in prima persona e con le proprie mani. Forse a molti consulenti e studiosi non interessano certi dettagli, ma le parole contano: anche a dire in inglese manifacture, la radice resta la latina “manufactura”, che significa “fatto con le mani”. L’imprenditore ha chiara la memoria di quando lui stesso era operaio. Se il figlio di un imprenditore riesce a prendere efficacemente in mano una PMI è perché conserva viva la memoria dell’esperienza del padre, ‘manifatturiera’ nel più pieno senso del termine. Si possono certo adottare sempre nuove tecnologie. Ma ciò che fa la differenza è la consapevolezza che la trasformazione della materia prima, la costruzione del prodotto, sono sempre frutto del congiunto pensare e lavorare con le mani. L’imprenditore italiano sa che automazione e software aggiungono sempre qualcosa, migliorano, semplificano e velocizzano, ma sa anche, senza ombra di dubbio, che non lascerà mai che l’agire pratico proprio e dei lavoratori che operano nella sua fabbrica venga sostituito da un comando, una regola di governo implicita nel software, dal codice che governa una macchina, da una qualche cosiddetta AI. Il lavoro umano ‘qui e ora’, nella fabbrica, è (e resterà sempre) la fonte del valore. Senza lavoro umano, senza esseri umani che pensano e muovono le mani non ci può essere né fabbrica né impresa. Questo gli imprenditori delle PMI italiane lo sanno così bene, lo ritengono tanto ovvio da non avere neanche bisogno di dirlo. Consulenza e accademia sono invece, purtroppo, portartici della convinzione che l’impresa italiana abbia un difetto: la ridotta dimensione delle imprese. Secondo la loro opinione queste dovrebbero crescere e assimilarsi al modello della grande impresa. Conviene, invece, comprendere che la virtù delle PMI italiane sta nella radicale differenza dalla grande industria. Una differenza culturale. Mentre nella grande impresa il lavoro umano è visto come labour cost, un mero costo da comprimere, e possibilmente eliminare, nelle PMI italiane la presenza di esseri umani al lavoro è intesa come un valore in sé e come la prima fonte di ogni costruzione di valore. Mentre la grande industria vede crescere la divaricazione tra il disegno – la strategia, il governo remoto – e una manifattura ridotta ad assemblaggio, le PMI italiane mantengono cortissima la distanza tra operai e tecnici: il cuore sta sempre nella fabbrica.Francesco Varanini ha lavorato per quattro anni in America Latina come antropologo. Quindi per quasi 15 anni presso una grande azienda, dove ha ricoperto posizioni di responsabilità nell’area del personale, dell’organizzazione, dell’Information Technology e del marketing.
Successivamente è stato co-fondatore e amministratore delegato del settimanale Internazionale.
Da oltre 20 anni consulente e formatore, si occupa in particolar modo di cambiamento culturale e tecnologico. Ha insegnato per dodici anni presso il corso di laurea in Informatica Umanistica dell’Università di Pisa. Attualmente tiene cicli di seminari presso l’Università di Udine.
Nel 2004, presso la casa editrice Este, ha fondato la rivista Persone & Conoscenze, che tuttora dirige.
Tra i suoi libri, ricordiamo Romanzi per i manager, Il Principe di Condé (edizione Este), Macchine per pensare.