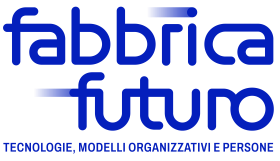L’antica sfida di fare impresa con le persone giuste

Lo stabilimento mi appare all’improvviso davanti agli occhi. Per raggiungerlo sono ricorso al navigatore satellitare destreggiandomi in un dedalo di strade anonime, tra centri commerciali di ultima generazione, capannoni di ogni sorta e ruderi di fabbriche abbandonate. Ora tutto è cambiato. Per esorcizzare l’emozione crescente mi viene spontaneo canticchiare: “Là dove c’era l’erba ora c’è una città…”. È vero!
Quando venni qui nel 1984 per la prima volta, davanti a un’enorme spianata incolta mi dissero che lì sarebbe sorta la nostra nuova azienda. Solo pochi anni prima un devastante terremoto aveva violentato l’Irpinia e la Basilicata, lasciandosi alle spalle morte e distruzione. Il Governo si impegnò, con ingenti risorse, a invogliare gli imprenditori –specie quelli del Nord– a investire laggiù e avviare un’opera non solo di ricostruzione, ma di vero rilancio di un territorio depresso e da sempre lasciato in balìa di se stesso.
Le risposte non mancarono. Ricordo in particolare, a più di 30 anni di distanza, la diffidenza che dapprima si respirava negli ambienti della casa madre torinese. L’idea di investire a 1.000 chilometri di distanza, il vincolo di poter assumere solo manodopera locale, il doversi confrontare quotidianamente con la politica e le istituzioni fornivano alibi sufficienti a lasciar cadere tutto nel nulla.
Solo un gruppo di dirigenti coraggiosi e visionari riuscì pian piano a convincere la maggioranza degli scettici e dei contrari ad accettare e, con il tempo, a trasformare una semplice scommessa in una storia vincente. All’epoca a me toccava il compito di curare la ricerca e selezione di tutto il personale e di accedere ai cospicui finanziamenti che il Fondo sociale europeo (Fse), a determinate condizioni, metteva a disposizione delle aziende investitrici.
Non dimenticherò mai le interviste a svariate centinaia di giovani ingegneri e periti industriali, così diversi dai loro omologhi del mitico Politecnico di Torino e dalle tute blu che nelle ‘boite’ della periferia del capoluogo subalpino padroneggiavano la Meccanica e l’Elettrotecnica con perizia sopraffina. Laggiù, tra montagne sperdute e in condizioni talvolta di fortuna, gli infiniti colloqui individuali e di gruppo e le simulazioni con case history, integrati da robuste dosi di artigiana creatività, misero più di una volta in crisi il mio talebanesimo sabaudo che ritenevo inattaccabile.
Stavo imparando a relazionarmi con un mondo nuovo e affascinante nella sua diversità dialettica e filosofica. Imparavo a ‘resettare’ il mio modo d’essere per interagire al meglio con una comunità locale che riponeva enormi speranze nel nostro operato. Il tutto tra le difficoltà di un contesto depauperato da ogni genere di infrastruttura! Il terremoto, infatti, aveva ancora lasciato ferite profonde nella terra e nelle persone, ma ormai la macchina era lanciata e nessuno avrebbe potuto più fermarla.
La fabbrica del Sud era diventata ‘la sfida’, la scommessa da vincere, e ciò fu tanto più chiaro quando i neoassunti cominciarono ad arrivare, un po’ tremanti di soggezione, nei severi headquarter torinesi per l’inserimento sul lavoro che poteva durare anche due anni. L’accoglienza fu calorosa e la collaborazione tra due mondi così differenti contribuì pure a costruire solide amicizie.
Persino la politica, normalmente attenta solo alle proprie esigenze, si rivelò inaspettatamente capace di rispettare e incoraggiare quei criteri di meritocrazia e di efficienza indispensabili alla realizzazione di un progetto di cotanta complessità. Ricordo infine l’emozione e la soddisfazione di ognuno di noi nel giorno del taglio del nastro, coincidente con l’inizio di una mia nuova sfida professionale in una diversa realtà e in un ruolo tutto da scoprire.
Gli anni successivi non fecero che confermare le ottimistiche premesse iniziali, suggellate da ultimo dalla quotazione in Borsa, affidata –per un sorprendente gioco del destino– ai colleghi della banca di cui facevo parte. Oggi ritorno un’altra volta qui. Rivedo questo angolo di Sud operoso e orgoglioso che seppe trovare, grazie al coraggio e alla volontà della sua gente, le risposte giuste alla sua atavica fame di lavoro.
Un messaggio inequivocabile a chi pensava –oggi come allora– di curare i mali di questa terra con la falsa medicina dell’assistenzialismo. Rileggo negli occhi delle persone la stessa vitalità di allora, colgo nelle parole la medesima vibrante umanità e un’antica signorilità divenuta, in questi tempi di violenta dialettica, merce sempre più preziosa. Mi accorgo di rimpiangere quell’Italia semplice, solidale e serena.